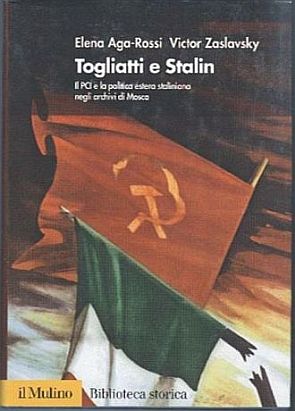
|
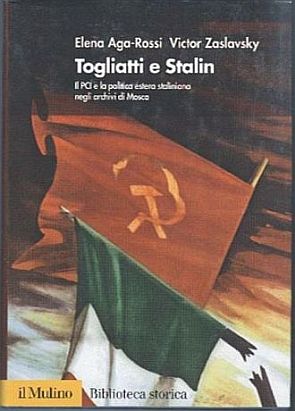
|
|
|
Edito da : Il Mulino - 2007 Questo libro, scritto in collaborazione con il marito, Victor Zaslavsky ha nella parte iniziale documenti inediti originali provenienti dagli archivi di Mosca, aperti al pubblico dopo la caduta del Comunismo, riguardanti la politica italiana dell'immediato dopoguerra. Contiene le traduzioni dei rapporti ai suoi superiori, nella persona dell'ambasciatore sovietico in Italia Mikhail Kostylev. Tema fra i più spinosi e discussi nella storia dell'Italia repubblicana, il rapporto tra il Pci e l'Unione Sovietica negli anni della guerra e del primo dopoguerra è affrontato qui a partire da un'ampia documentazione di parte sovietica : soprattutto dai resoconti degli incontri di Togliatti e degli altri dirigenti del Pci con l'ambasciatore sovietico, emerge un quadro stupefacente dell'allineamento del partito italiano agli obiettivi della politica estera sovietica. Gli autori mostrano come le scelte politiche del Pci - dalla svolta di Salerno alla questione di Trieste, alla "rivoluzione mancata", all'atteggiamento sul rimpatrio dalla Russia dei prigionieri, all'opposizione al Piano Marshall - fossero largamente determinate dalle esigenze della politica estera di Stalin. La "doppiezza" comunista non risiedeva tanto nella compresenza di un'anima legalitaria e di un'anima rivoluzionaria, quanto nella doppia identità di partito nazionale e frazione di un movimento comunista internazionale guidato dall'Unione Sovietica. Il libro, pubblicato nel 1997, viene ripresentato nel 2007 in un'edizione notevolmente ampliata e arricchita dai risultati delle ricerche recenti e da nuovi documenti inediti. Recensione-intervista del settimanale "Espresso" ad Aga Rossi e Victor Zaslavsky - 18 luglio 2007 di Nello Ajello Elena Aga Rossi, negli anni Ottanta e primi Novanta i suoi libri più noti, da "L’Italia nella sconfitta" a "Una nazione allo sbando", riguardavano le vicende del nostro paese sullo scadere del fascismo. Che cosa l’ha indotta a orientare i suoi studi verso la storia della sinistra italiana ? «In realtà – risponde la studiosa – la storia dei partiti politici è stato il mio interesse originario. Mi sono laureata con una tesi su Giustizia e Libertà e il partito d’Azione. Un’antologia di documenti relativi al partito di Parri e La Malfa uscì nel ‘69 a mia cura. Nello stesso anno pubblicai un volume sulla transizione dal Partito Popolare alla Dc. Ma proprio queste esperienze mi mostrarono come fosse incompleta una storia dei partiti condotta con un’ottica solo nazionale. Convinzione di cui ebbi conferma durante due anni di studio (1969-71) trascorsi ad Harvard. Poi, la conoscenza di Zaslavski è stata determinante nel senso di allargare i miei orizzonti di ricerca al di là dell’Occidente». Zaslavski, per il suo lavoro è stata determinante la possibilità di esplorare gli archivi sovietici. Quali ostacoli ha dovuto superare per avervi accesso ? E oggi, è facile esplorarli ? «Nel ‘92, insieme ad Elena Aga Rossi, tentammo per la prima volta, invano, di consultare gli archivi di Mosca. Il tentativo riuscì l’anno successivo, grazie a un accordo culturale tra la Fondazione Feltrinelli e l’archivio del Ministero degli Esteri russo, che prevedeva la possibilità, per alcuni studiosi – fra i quali noi due – di accedere ai materiali archivistici del Ministero stesso. Da lì proviene gran parte dei documenti di cui ci siamo valsi per "Togliatti e Stalin". E oggi ? Direi che negli ultimi quindici anni la situazione è peggiorata. Restano escluse dalla consultazione – cito un solo caso – le carte di Stalin e di Molotov. L’era Putin ha segnato un sostanziale arretramento». Alla sua prima comparsa, dieci anni fa, "Togliatti e Stalin" suscitò aspre polemiche. Vi si colse un attacco alla personalità del leader del Pci, al quale si accreditava un’autonomia politica da Mosca che voi contestavate. «Allora, nel 1997 – risponde Aga Rossi – le discussioni si concentrarono sulla svolta di Salerno, che veniva considerata il personale capolavoro del segretario del Pci. Chi, fra gli storici, più aveva puntato su questa interpretazione, trovò difficile accettare una versione che nettamente la negava. Oggi si può registrare un certo grado di accettazione delle radici internazionali – per essere più chiari, dell’origine sovietica – di quell’evento. Risulta sempre più lampante l’impossibilità a quei tempi, per un partito comunista, di assumere una decisione di simile portata – cioè il riconoscimento della monarchia e la partecipazione a un governo «borghese» – senza l’avallo e il consenso di Stalin». Ma la svolta di Salerno è solo uno dei temi trattati in quel volume. «Certamente. I rapporti fra Pci e Pcus – interviene Zaslavski – influenzavano molte altre situazioni. Faccio un esempio. Quando in Italia si profilava un cambio nel personale nei paesi dell’Est, il Pci rendeva noto al partito sovietico il nome designato dal governo di Roma per coprire l’incarico. Si chiedeva, insomma, il placet del Cremlino. C’è da domandarsi se una nazione democratica dell’Occidente potesse avere nel proprio governo i rappresentanti di un partito che intratteneva un simile legame con una potenza straniera. E’ proprio di fronte a fatti di questo tipo, da noi riesumati, che ancora prevale tra gli storici italiani un atteggiamento di rimozione. Tarda a svilupparsi un discorso generale sul ruolo svolto per decenni dal Pci nella vita politica italiana, sui condizionamenti internazionali di quel partito e sulle conseguenze che ne derivavano». Quali sono le novità contenute nella nuova edizione di "Togliatti e Stalin" ? «Abbiamo esaminato – racconta Aga Rossi – documenti e testi storici apparsi di recente sia in Russia che nel paesi dell’ex blocco sovietico. Per esempio, il diario di Georgi Dimitrov, primo segretario del Comintern. Altra novità: diamo ampio spazio, nel volume, al resoconto di un’importante riunione che si svolse a Mosca il 10 febbraio 1948. Vi presero parte, con Stalin, i leader dei partiti comunisti jugoslavo e bulgaro. Era all’ordine del giorno l’opportunità o meno di continuare ad aiutare la rivoluzione comunista in atto in Grecia. Si profilò il proposito di bloccare gli aiuti ai greci insorti, nella convinzione che il proseguimento della sollevazione avrebbe indotto gli Stati Uniti a intervenire militarmente. Sia questa valutazione del “caso greco”, sia la rottura intervenuta fra Mosca e Belgrado aiutano a spiegare il “no” di Stalin a una sollevazione armata in Italia». Spicca nel vostro libro la definizione di Togliatti come uno «stalinista moderato». «A Togliatti – dice Zaslavski – un merito va infatti riconosciuto : l’aver ostacolato all’interno del Pci le tendenze più massimaliste. Anche nei rapporti con Stalin si registrano, da parte sua, alcune prese di posizioni responsabili, in contrasto con quelle assunte da altri esponenti del partito, a cominciare da Pietro Secchia. Risulta eloquente, a questo proposito, un episodio che risale al marzo del ‘48, vigilia di elezioni decisive. Tramite l’ambasciatore sovietico a Roma, Mikhail Kostylev, Togliatti rivolge a Stalin una domanda precisa : nel caso di una vittoria popolare della sinistra, qualora la Dc tentasse di annullarla, come dovrebbe reagire il Pci ? Quasi che egli volesse sentirsi dire: per carità, non muovetevi. Probabilmente, come abbiamo visto, Stalin era già convinto in questo senso, ma la moderazione di Togliatti poté servirgli da conferma». Come si spiega, a vostro parere, lo scarso seguito che hanno riscosso in Italia le posizioni dell’anticomunismo democratico ? «Qui da noi – osserva Aga Rossi – il vero liberalismo è stata sempre una pianticella gracile. La sua crescita è stata ostacolata, con una convergenza di fatto, dai due maggiori partiti, comunista e cattolico. Penso, per esempio, al ruolo di minoranza in cui venne relegato, negli anni Cinquanta e Sessanta, un gruppo come quello del Mondo. Si può aggiungere che fino agli anni Novanta, a sinistra, il termine “riformista” equivaleva per lo più a un’ingiuria». Qual è il vostro giudizio sulla politica dei successori di Togliatti, dai tempi di Berlinguer fino alla caduta dei muri ? «Prenderei le mosse – dice Zaslavski – dall’invasione della Cecoslovacchia, estate 1968. Essa ebbe un doppio effetto. Dimostrò che il sistema sovietico era irriformabile e accompagnò lo sviluppo, in Unione sovietica, di un movimento di dissenso e di un flusso migratorio di natura politica. Allo stesso tempo nasceva o rinasceva in molti l’illusione che fosse possibile arrivare a un comunismo democratico, senza più l’intervento dei carri armati del Patto di Varsavia. Così, negli ultimi vent’anni del regime sovietico apparvero tragiche figure di leader, come Berlinguer e come Gorbaciov». In che senso, figure tragiche ? «Nel senso, conclude Aga Rossi, che erano accomunati dalla speranza in un comunismo dal volto umano. Con il suo eurocomunismo, Berlinguer ipotizzava una terza via tra gli ideali socialdemocratici e il regime comunista : qualcosa, cioè, che per Mosca era inaccettabile in quanto equivaleva a una sconfitta nella storica lotta ingaggiata, appunto, contro la socialdemocrazia. Gorbaciov puntava a sua volta su un suo disegno utopistico : democratizzare l’Urss e in pari tempo mantenere l’integrità dell’impero sovietico. Nei fatti, quanto più successo otteneva la perestrojka più instabile diventava il potere sovietico. E così al crollo dei muri seguì la divisione dell’Unione sovietica in quindici paesi indipendenti e la scomparsa del comunismo internazionale». |
|
|
|
|